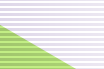FILM
Aprile-Maggio
2000
Tra
Shakespeare e l’antica Roma
Segnalati
da Nautilus
Il
gladiatore di Ridley Scott
Fortunatamente il cinema riserva
spesso delle belle e imprevedibili sorprese. Così un
regista che si pensava avesse già dato il suo meglio con Blade
Runner, Alien e Thelma & Louise torna
prepotentemente alla ribalta con un film originale e
sorprendente. Il gladiatore di Ridley Scott, infatti,
costituisce una sorta di reinvenzione di un genere
cinematografico dove l’utilizzo della tecnologia
digitale è stata capace di sostituire il termine kolossal
con la più ambita definzione di
‘pellicola d’autore’. Già, perché
nonostante il film prenda le mosse da dove iniziava anche Quo
Vadis? ovvero dalla guerra di Marco Aurelio contro
Quadi e Marcomanni nei pressi di Vindobona (l’attuale
Vienna) il suo sviluppo è abbastanza dissimile e
originale. Massimo interpretato da uno straordinario
Russel Crowe è un generale che non nasconde le sue
origini contadine, di cui va fiero come simbolo di onestà.
Profondamente attaccato alla sua famiglia lasciata a casa,
è un soldato coraggioso e formidabile, incrollabilmente
fedele a Roma e al suo imperatore, amatissimo dai suoi
soldati. Quando Marco Aurelio presagendo la fine
imminente, gli chiede di restituire la città alla
Repubblica, Massimo si fa garante con la sua parola. Una
scelta che gli costerà cara, visto che il feroce figlio
dell’imperatore, Commodo si vendicherà ben presto.
Sfuggito ad un assassinio a tradimento, Massimo – finito
in una lontana provicina africana - diventerà il
gladiatore più famoso dell’impero. E vivrà una vita
relativamente tranquilla fino a quando – tornato a Roma
– dovrà affrontare i fantasmi del suo passato, laggiù
nel Colosseo dove la folla che ti ama è disposta a
seguirti anche in imprese disperate.
Al di là delle ricostruzioni
computerizzate mozzafiato della Roma imperiale (sembra
quasi di essere caduti nel plastico del Museo della civiltà
romana all’Eur) la grande forza de Il gladiatore sta
nel raccontare una storia dalle venature New Age in cui il
cristianesimo non viene quasi mai citato e dove –
evitando così le possibili melensaggini cui ci avevano
malamente abituate alcune pellicole del passato anche
famose – il protagonista è un eroe pagano fedele alle
leggi della città e devoto. Il gladiatore –
nonostante qualche errore storiografico francamente
trascurabile dinanzi alla grandiosità della pelicola –
si propone così come un film commovente ed emozionante,
in cui si celebra il trionfo dell’immagine. Le
spettacolari battaglie contro i barbari e i sontuosi
giochi del circo consegnano definitivamente la celeberrima
corsa delle bighe di Ben Hur alla storia del
cinema. Intepretato da Joaquin Phoenix, Connie Nielsen (L’avvocato
del diavolo) da Oliver Reed morto durante le riprese a
Malta e aggiunto in digitale nelle scene mancanti, Djimon
Honsou (Amistad) il film annovera nel cast anche
due straordinari grandi vecchi del cinema britannico come
Derek Jacobi e Richard Harris nei panni già vestiti da
Alec Guinnes di Marco Aurelio. Ma l’elemento più
notevole e di valore all’interno del film resta al di
fuori di ogni dubbio la grande interpretazione di Russel
Crowe che con il suo aspetto di eroe triste ci comunica lo
sgomento di un uomo giusto di fronte al tradimento e alla
corruzione. In tal senso l’integrità del protagonista
risulta quasi singolare:
Massimo è il primo eroe vero senza macchia e senza paura
trapiantato nel Duemila. Una scelta vincente dopo un
numero cospicuo e forse eccessivo di antieroi. Il suo
laicismo, la sua fede nella lealtà ce lo rendono
enormemente simpatico e caro come un amico prezioso e
insostituibile rincontrato dopo lungo tempo. Il
gladiatore è la dimostrazione che quando ci mette lo
zampino Spielberg e la sua compagnia di produzione, il
cinema può compiere dei miracoli come riuscire a inondare
di nuova linfa generi cinematografici apparentemente senza
alcuna prospettiva. Una taumaturgia che con Il
gladiatore sortisce il benefico effetto di realizzare
una pellicola emozionante sebbene di vecchio stampo. Una
visione moderna e avanzata di storie antiche, ma ancora
cariche di fascino e forza espressiva perfettamente
plasmata da un vecchio leone come Ridley Scott.
Titus
di Julie Taymor
Drammatico senza solennità,
deflagrante senza acrimonia, appassionato con la gelida
freddezza derivata dall’esplosione di vendetta e rabbia,
Titus è una pellicola sconvolgente. Un distillato
onirico e visionario del bestiario umano di Federico
Fellini e del talento visivo di Peter Greenaway. Una
pellicola appassionante profondamente fedele al testo di
Shakespeare, che (in barba alle recenti riletture buoniste
dell’opera del bardo di Stratford - on – Avon) mette
in scena in maniera strabiliante sentimenti e situazioni
peccaminosi come rabbia, odio, violenza, stupro, omicidio
e ambizione sullo sfondo di una Roma imperiale che risulta
dalla fusione del carattere maschilista e fascista dei
palazzi dell’Eur voluti da Mussolini, con lo scombinato
e pittoresco dedalo della Roma rinascimentale sorta
intorno ai ruderi romani. Lo stile architettonico della
Roma fascista dell’Eur alternato alle campagne di ruderi
della via Appia costituiscono lo sfondo su cui si muove
Tito Andronico, valoroso generale caduto in disgrazia
presso l’imperatore che lui stesso ha fatto eleggere
rinunciando alla carica e che subisce il fascino malefico
della regina gota Tamora. I congiunti del soldato vengono
uccisi con l’inganno e oltraggiati, la figlia Lavinia
stuprata e mutilata dai figli di Tamora mentre Titus si
affligge per i suoi mali, dilaniato tra la rabbia
furibonda e la fedeltà alla sua città. Il senso
dell’onore oltraggiato camuffato astutamente sotto il
velo di una finta pazzia porteranno il film a un finale
tragico in cui viene celebrato il trionfo della vendetta a
tutti i costi. Collocato in uno spazio al di fuori del
tempo, il film si nutre di un background visivo
appassionante che risulta dall’alchimia magmatica della
città di oggi con il carattere quasi archetipico dei suoi
monumenti architettonici. In tal senso sin dalle prime
scene il film si apre su una gestualità militare quasi da
teatro Kabuki per riportare alla sua essenzialità
primigenia il testo shakesperiano collocato in un’era
stratificata e cristallizzata che permette la convivenza
di un’anima arcaica con una molto moderna, quasi da era
dei dittatori. Un melting pot in cui tutti sono
buoni e cattivi al tempo stesso, profondamente
influenzato dal genius loci latino in cui
convivono perfino i colori delle squadre calcistiche della
capitale per indicare la fazione politica dei suoi
appartenenti. Divise, armature e armamenti dal design frutto
di un incontro tra passato e presente, coprono i corpi che
nudi si riversano poi in lascive vasche d’acqua che
ricordano pellicole come Satyricon o Caligola. Un
film affascinante e stupefacente in cui il trionfo del
testo shakesperiano ha la meglio perfino sul politicamente
corretto di alcune interpretazioni moderniste.
Straordinaria la regia della Taymor coadiuvata dalla
sottile demenza che Antony Hopkins si è autoimposto per
tutto il film e che si scontra in maniera micidiale e
perfetta con il languore erotico della regina Tamora
interpretata da un’ancora vorace Jessica Lange. Un film
molto particolare Titus, in cui il dramma trova
contemporaneamente una consacrazione dal timbro molto
moderno e una celebrazione al di fuori del tempo, che con
la sua virulenza espressiva carica dell’adrenalina delle
pulsioni umane costringe la regia ad abbassare il tono
lirico del testo in favore di una più carica di
significato espressività di natura fisica. Sono, infatti,
i corpi a dominare lo spazio dell’azione drammatica,
arcigna e cruenta sin dalle primissime scene. Una tensione
narrativa, sublimata da un contesto visuale ben delineato
che accompagna sin dall’inizio lo spettatore verso
un’implosione della struttura narrativa, e che riesce a
liberarlo solo dopo un finale catartico dove – con la
vittoria della ragione rappresentata dal ripristino delle
leggi degli uomini – è possibile perfino dare vita a un
happy ending fuori posto di natura New Age. Nella
sua caotica rabbia e nel suo tono grottesco e languido, Titus
è davvero lo specchio della nostra epoca mediato
attraverso il genio di Shakesperare e il talento visivo di
Julie Taymor.
Pene
d’amor perdute di Kenneth Branagh
Gli ultimi film tratti da Shakespeare
ci avevano abituato fin troppo bene. La potenza violenta e
non rassicurante di Titus di Julie Taymor trova
due brillanti alter
ego raffinati
e altrettanto virulenti nel Riccardo III di
Richard Loncraine con protagonista Ian Mc Kellen e in
Romeo + Juliet di Baz
Luhrman con Leonardo Dicaprio. Poi sono arrivati film
classicheggianti e meno riusciti come La dodicesima
notte di Trevor Nunn e Sogno di una notte di
mezza estate. Adesso il tanto atteso Pene d’amor perdute con
protagonista Kenneth Branagh, l’attore regista che ha
riportato l’opera del bardo di Stratford on Avon al
centro dell’attenzione cinematografica, tradisce in
qualche maniera lo spirito sempre innovativo dei suoi
predecessori. Dimenticata la grandiosità della messa in
scena dell’Hamlet ambientato nell’era
asburgica e trascurata la genialità della rilettura di Nel
bel mezzo di un gelido inverno, Branagh sceglie di
andare sul sicuro. Ambientando il film negli anni Trenta,
alla vigilia dello scoppio della seconda guerra mondiale,
l’attore britannico si è circondato di un nucleo di
attori straordinari per mettere in scena una commedia
romantica basata su inganni ed equivoci spassosi. Il re di
Navarra e suoi tre fedelissimi giurano di non innamorarsi
per almeno tre anni, dedicandosi allo studio della
filosofia. L’arrivo della figlia del re di Francia e
delle sue tre belle dame, sconvolgerà i loro piani. La
grande forza del film sta essenzialmente nel suo cast ben
assortito e di grande qualità: c’è la bella Natascha
McElhone già vista in Ronin
e Surviving Picasso di Ivory con il quale aveva esordito
sul grande schermo, lasciando momentaneamente la Royal Shakespeare Company, c’è
l’ex Batgirl
Alicia
Silverstone, ci sono due veterani del cinema e della
commedia Nathan Lane e Timoty Spall e ci sono –
soprattutto per noi -
i due attori italiani Alessandro Nivola e Stefania
Rocca. Ma purtroppo Pene d’amor perdute, nonostante
la deliziosa cornice a metà tra la fiaba hollywoodiana
(con tanto di finti cinegiornali) e il musical
jazzato da
innumerevoli standards cantanti dai protagonisti, non riesce ad andare oltre una leggiadria di
fondo che – alla lunga – risulta stucchevole.
Tutt’altro che geniale, notevolmente statico, il film si
perde per colpa di una realizzazione povera di mezzi che
pur seguendo pedissequamente le orme delle commedie
musicali americane di prima della Seconda guerra mondiale,
non è in grado di ricrearne adeguatamente lo stesso
spirito con brio e freschezza. E come potrebbe farlo del
resto a cinquanta anni e passa di distanza? Il cinema non
è un esperimento scientifico e il tempo trascorso si nota
sempre e comunque. Così nonostante alcuni guizzi in cui
Branagh sembra riconquistare momentaneamente la forma
perduta, il film rimane soltanto un omaggio pedissequo e
discontinuo ad un tipo di cinema a tutt’oggi ancora
imbattuto sul campo della spregiudicatezza e al tempo
stesso della leggiadria. Un po’ come il mediocre Tutti
dicono I love you di Woody Allen che non era
nulla di più di una parabola plutocratica, Pene
d’amor perdute ha la peggio nel confronto con il
passato. L’operazione di intramezzare canzoni jazz alle
parole di Shakespeare non sortisce alcun effetto degno di
piacevole nota. Un po’ perché la fusione risulta
comunque ‘posticcia’, un po’ perché condensato in
un’ora e mezza di testo abbastanza fedele
all’originale, lo scarto tra musica, immagini e parole
non presenta alcunché di davvero sorprendente o
innovativo. Pene
d’amor perdute si
risolve così in una variazione sul tema, un esercizio di
stile dove – nonostante la buona volontà di tutti –
non si riesce a superare quella barriera che porta nel
difficile terreno del genio. Luogo ben conosciuto
dall’attore e regista inglese, che sembra averlo
inspiegabilmente e frettolosamente lasciato per una
pellicola dalle coreografie piatte e dai rari momenti
interessanti. Una piccola consolazione personale ci è
data dal fascino procace di Stefania Rocca che ben regge
il confronto con la McElhone, e che ci colpisce per la sua
consueta simpatia e avvenenza.
I ragazzi del Marais di Jean Becker
Tratto
da un romanzo di George Montforez, I ragazzi del Marais
è un film per molti versi eccezionale. Diretto da
Jean Becker, si presenta agli occhi dello spettatore
mostrando una grande serenità e semplicità, ottenuta
sullo schermo a dispetto dei circa 1.500 ciak dati del
regista per ricreare in pieno le atmosfere del libro. Un
compito certo non facile per raccontare una storia di
umili che rischiava di finire nell’oblio capitalista
della New Economy. I protagonisti della storia sono,
infatti, dei “morti di fame” per loro stessa
ammissione che vivono intorno ad una palude vicino a un
piccolo paese della provincia francese. Uomini semplici
alla ricerca continua di lavoretti da giardiniere o da
carbonaio, per comprare qualcosa da mangiare per sé e i
propri figli. Personaggi apparentemente ordinari, animati,
però, da un considerevole rispetto di se stessi e della
propria dignità al punto da non volere accettare un
congruo assegno staccato da uno di loro diventato per caso
e per fortuna un ricco industriale. “Così
diventeremmo dei pezzenti” dice
uno di loro all’amico che sembra avere dimenticato il
codice non scritto dell’onestà dei semplici che si
affitta, ma non si compra. Una storia dirompente, lontana
dai valori plastificati del politicamente corretto che
come nel Gladiatore di Ridley Scott esalta
il vero valore della lealtà, dell’amicizia e
dell’onestà. “Sono
francamente stufo dei ladri gentiluomini e delle
sparatorie cui ci sottopone il cinema di oggi” – dice
il regista Jean Becker – “Io
credo che il cinema abbia bisogno di eroi disarmati capace
di trasmettere dei valori alle nuove generazioni. E’
questo il compito di un film e più in generale
dell’arte.” La poesia e il grande divertimento presenti ne I
ragazzi del Marais sono dovuti in
grandissima parte al talento del cast di attori scelti
dall’autore. Uomini e donne (strepitoso è l’ex
calciatore Eric Cantona nel ruolo di un pugile sfortunato)
in grado di raccontare il piacere e la bellezza di una
vita precaria senza padroni, lontano dai sentimenti di un
capitalismo sfrenato in cui la felicità era data da un
buon bicchiere di vino, da una coscia di rana fritta o da
un semplice pallone. Un film fatto di piccole cose che
diventa un’epopea degli umili con ironia e lontano da
ogni retorica, volutamente incapace di nascondere il suo
profondo ottimismo a dispetto di tutte le accuse
riguardanti ‘i buoni sentimenti’. Cui il regista
risponde così “Ho
amato molto un film come Il postino di Massimo Troisi.
L’unica cosa che non mi piace, però, è il finale.
Dobbiamo avere il coraggio di raccontare storie capaci
ancora di farci sognare.”
Sogni
di bambini come una bambola di pezza, una palla o una
giornata al parco con un amichetto in barba al custode che
non fa entrare i figli dei poveri: “Nel
Natale del 1941 ho ricevuto un cavalluccio di legno. E’
stato il più bel regalo della mia vita.” –
dice il regista – “Questo
film, che in Francia è stato molto apprezzato dai
giovani, serve a riscoprire il valore delle cose
semplici.”
Ogni
maledetta domenica di Oliver Stone
Perché uno dei registi americani più
impegnati sul versante politico, autore di film come JFK,
Nixon e Assassini Nati dovrebbe occuparsi di
football? Perché un autore tumultuoso e mai prevedibile
come Oliver Stone dovrebbe dire quello che tutti in parte
già sanno: ovvero che lo sport è stato corrotto dalla
valanga di soldi connessa ai diritti televisivi,
trasformando le squadre in aziende multimiliardarie che
hanno ben poco a vedere con lo spirito del gioco e di
squadra? “Perché per me il football è la metafora
della vita. Una guerra non molto dissimile dal Vietnam
dove sono finito da giovane in cui sudi e ti sacrifichi
anche solo per guadagnare un centimetro. E non mi piace
quello che questo sport è diventato oggigiorno. Un
crogiuolo di interessi economici e di mercenari che
giocano per loro stessi.” Dice il regista che in Ogni
maledetta domenica ha voluto raccontare la battaglia
settimanale che un allenatore vecchio stampo e dal cuore
d’oro come Al Pacino è costretto a combattere non solo
contro avversari tatticamente preparati ed agguerriti, ma
anche contro l’ingerenza della ricca proprietaria,
ereditiera della squadra Cameron Diaz. Fautrice di meri
interessi economici e disposta pure a far giocare chi non
è in perfetta condizione fisica pur di raggiungere i suoi
scopi. Ogni maledetta domenica lungo ‘solo’ due
ore e mezza nella versione europea, tagliata di dodici
minuti rispetto a quella americana per rendere più
comprensibile il gioco a chi non lo conosce, è la
narrazione del mondo corrotto e fatuo delle squadre di
football, alle spalle del quale non c’è soltanto un
modo diverso di intendere il gioco, ma addirittura due
filosofie di vita distanti e spesso inconciliabili. In
questo senso Dennis Quaid il Quaterback per cui
tutti si sacrificano e che è arrivato alla fine della sua
gloriosa carriera rispettato da tutti è l’alter ego
perfetto per il giovane giocatore nero Jamie Foxx, che
dopo anni di umiliazioni dovuti a pregiudizi striscianti
ed essere alla fine riuscito a conquistare fama e denaro,
si propone come il prototipo dei campioni inondati dai
soldi, incapaci di servire lo spirito di squadra. Poi –
non solo di contorno – c’è tutto il resto: il medico
corrotto James Woods, il giornalista sportivo egocentrico
e pieno di sé che si scontra contro il telecronista tutto
cuore e ricordi interpretato dallo stesso Oliver Stone,
l’anziano dirigente della lega Charlton Eston (quasi un
doppio ruolo il suo visto che in casa dell’allenatore un
televisore trasmette Ben Hur…), le tante donne
stupende che ruotano intorno ai giocatori in veste di
mogli o amanti anche loro – comunque – mercenarie. Una
guerra sportiva a tempo di rock, questa in estrema sintesi
Ogni maledetta domenica che al pubblico italiano
obnubilato dalle partite di calcio e dagli scandali
sportivi a tutte le ore non sembrerà poi così virulento
come nelle intenzioni del regista. Una pellicola
certamente spettacolare e interessante in cui la metafora
del gruppo in grado di vincere unito rispetto a chi
subisce le sconfitte da soli, è la stessa che il regista
americano ci aveva già proposto in Platoon. Un
altro modo per dire che nella società
dell’individualismo sfrenato è solo la famosa unione
che fa la forza in grado di fare la differenza e
vincere. Una visione filosofica della vita
originale anche se un po’ retrò, ma anche – e
questo è fuori di dubbio – un messaggio politico molto
importante per un regista democratico come Oliver Stone.
Erin
Brockovich di Steven Soderbergh
Erin
Brocovich è
un film estremamente riuscito, perché offre al pubblico
numerosi piani di lettura diversi. Innanzitutto quello di
essere stato ispirato da una storia vera in cui l’Erin
Brocovich della vita reale appare addirittura in un
piccolo cameo come cameriera di una tavola calda
dove a sua volta la finta Erin Brocovich interpretata da
Julia Roberts va a mangiare con i tre figli molto piccoli.
Il secondo punto di vista è quello della storia di una
donna sola che messa alle strette dalla mancanza di denaro
e da due matrimoni falliti cerca a tutti i costi un posto
di lavoro per mantenere i suoi bambini. Poi c’è il thriller
legale in cui Erin cerca con molti sacrifici e tanto
ingegno di aiutare gli abitanti di una piccola cittadina
la cui acqua è stata avvelenata da delle sostanze
chimiche passate dagli scarichi di una fabbrica nelle
falde acquifere. E ancora, c’è la storia di una donna
affascinante e del suo difficile rapporto con gli uomini.
Insomma, Erin Brocovich si giova di quella
completezza e originalità che solo la vita vissuta può
donare alle storie. Il regista Steven Soderbergh è stato
bravo a riunire le fila di tutti questi aspetti differenti
e plasmarli in una pellicola veloce, interessante e non
priva di ironia e di momenti di grande divertimento. Al di
là del motivo didascalico che descrive quanta forza
d’animo e di volontà ci vogliono per cambiare il
fatidico stato delle cose, l’elemento più interessante
racchiuso nel film è quello fornito dalla grande umanità
di Julia Roberts capace di interpretare in maniera diretta
e senza troppi fronzoli un personaggio vero e intenso.
Nonostante sia un lungometraggio prodotto da uno dei
grandi Studios hollywoodiani e abbia come protagonista
quella che può essere considerata la più grande tra le star
di sesso femminile, Erin
Brocovich è
una pellicola dalla natura indipendente esaltata da un budget
adeguato e
dalla regia di un autore che dopo L’inglese
con Terence
Stamp torna a presentare un film più tranquillo sul piano
visuale, ma non meno intrigante e interessante dal punto
di vista narrativo e di quello delle emozioni.
Vai
alla seconda parte
|