Storie (vere)
di ordinaria follia
Porte
chiuse, mura insormontabili, l'isolamento dal mondo. E
l'abbandono anche psicologico dei malati. A cui, a volte,
basterebbe un sorriso e qualcuno che li ascolta. Come ha fatto
un'ex infermiera di manicomio. Che racconta in un libro la
sua esperienza
Anna
Maria Meggiolaro, Terzo reparto donne, L’Autore Libri
Firenze, pp.239, L.28.000
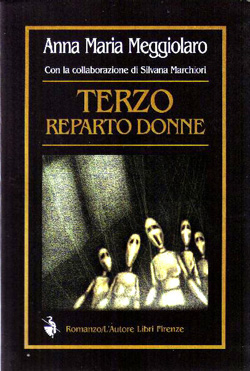 Non
ha eccessive ambizioni letterarie, né saggistiche il libro di
Anna Maria Meggiolaro e la collaborazione di Silvana Marchiori.
E’ semmai una testimonianza accorata intorno all’universo
concentrazionario manicomiale da parte di una osservatrice
privilegiata, che, finito il proprio lavoro, poteva almeno
evadere per qualche ora di riposo da quella sorta di prigione
dove erano segregati i folli e coloro i quali li vigilavano.
E’ in uno scenario da carcere che si apre, infatti, “Terzo
reparto donne”: lungo resoconto autobiografico scritto da
un’ex infermiera, cioè da chi – ben più dei medici –
era a stretto contatto quotidiano con l’alienazione più
devastante: quella mentale.
Non
ha eccessive ambizioni letterarie, né saggistiche il libro di
Anna Maria Meggiolaro e la collaborazione di Silvana Marchiori.
E’ semmai una testimonianza accorata intorno all’universo
concentrazionario manicomiale da parte di una osservatrice
privilegiata, che, finito il proprio lavoro, poteva almeno
evadere per qualche ora di riposo da quella sorta di prigione
dove erano segregati i folli e coloro i quali li vigilavano.
E’ in uno scenario da carcere che si apre, infatti, “Terzo
reparto donne”: lungo resoconto autobiografico scritto da
un’ex infermiera, cioè da chi – ben più dei medici –
era a stretto contatto quotidiano con l’alienazione più
devastante: quella mentale.
“Al
reparto neurologico si accedeva attraverso una solida porta
chiusa da una doppia mandata”, ricorda l’autrice,
sottolineando il regime di isolamento assoluto che
caratterizzava i vecchi ospedali psichiatrici. “Le
chiavi”, continua il testo, “costituivano una presenza
costante e a mio avviso inquietante in quel reparto; chiuse
erano le porte, chiuso l’ingresso, chiuso il corridoio
spazioso, chiuso l’ufficio medico”. Non a caso torna con
una reiterazione incisiva il termine chiuso,
a indicare lo scopo principale dell’antico manicomio: essere
in primo luogo un reclusorio in cui isolare dal mondo dei sani
di mente i cosiddetti matti.
Ed
è davvero uno scenario “da incubo” quello che si presenta
agli occhi della giovane infermierina
che il lontano sette febbraio 1967 varca per la prima
volta la soglia dell’ospedale psichiatricio di Vicenza:
cittadella della follia, recintata da alte mura e serrata da
un cancello di ferro a protezione dal mondo e del mondo. Visi
di donne che avevano chissà da quanto smarrito non solo la
ragione ma anche la loro umanità, assumendo ora i tratti
bestiali dell'ira, ora l’apatia catatonica di chi ha perso
tutto e non s’aspetta più nulla. Queste le “croniche”:
degenti bollate a priori con una parola orribile, che già di
per sé rimanda ad un’idea di ineluttabile inguaribilità.
Poveri esseri costretti in una spenta divisa carceraria a
consumare giorni vuoti in attesa del nulla e curate, oltre che con
dosi massicce di psicofarmaci, con lettini di contenzione,
camicie di forza ed elettroshock.
Eppure
giorno dopo giorno, umilmente – come una specie di angelo in
gonnella dai capelli rossi – la giovane infermiera, sapendo
restare accanto con un’istintiva empatia compassionevole
alle malate, riesce talvolta nel piccolo miracolo di far
sbocciare in quei visi spenti un sorriso; ottiene che le loro
farneticazioni monologanti si tramutino – sia pure per il
breve istante di una richiesta d’aiuto – in dialogo; fa sì
che le pazze tornino persone. E questo, rifiutandosi
caparbiamente di considerarle croniche, appunto. Anche
soltanto limitandosi a regalare a tutte il dono
dell’ascolto, d’una vicinanza conquistata con una carezza,
uno sguardo o una parola gentili.
Poi
verrà il tempo di Basaglia, la chiusura dei manicomi e, da
parte della ex ragazza dai capelli rossi, l’opportunità di
andare ad operare presso un’altra struttura. Ma il ricordo
di quegli anni insieme bui e luminosi non verrà mai meno e
nascerà in Anna Maria Meggiolaro l’urgenza di testimoniare
la sua esperienza nella cittadella della pazzia. Questo il
significato di “Terzo reparto donne”: una confessione
autenticamente fresca. Una scrittura senza orpelli ma lineare
e sincera; nella consapevolezza amara che – per buona parte
delle croniche –, smantellato il protettivo reclusorio, è rimasta
intatta “forse solo la condizione, ben più atroce della
loro segregazione mentale”.
Francesco
Roat
