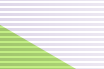CREMONA – L’arte e il torchio

 Dal 7 marzo al 7 aprile, presso la sede
dell’A.D.F.A. casa Sperlari di Cremona, si terrà la "I° Rassegna
Internazionale dell’incisione di piccolo formato" a cura dell’incisore
Vladimiro Elvieri e con il patrocinio, del Comune e della Provincia di Cremona. Saranno
presenti 165 opere a stampa eseguite a partire dal 1990 ad oggi da 83 tra i più
significativi incisori contemporanei provenienti da 27 Paesi di 4 continenti.
Dal 7 marzo al 7 aprile, presso la sede
dell’A.D.F.A. casa Sperlari di Cremona, si terrà la "I° Rassegna
Internazionale dell’incisione di piccolo formato" a cura dell’incisore
Vladimiro Elvieri e con il patrocinio, del Comune e della Provincia di Cremona. Saranno
presenti 165 opere a stampa eseguite a partire dal 1990 ad oggi da 83 tra i più
significativi incisori contemporanei provenienti da 27 Paesi di 4 continenti.
La mostra sarà accompagnata da un catalogo bilingue italiano-inglese con testi
critici del filosofo dell’arte Dino Formaggio, del critico dell’arte 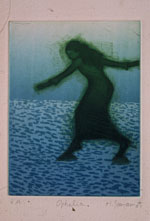 grafica Marco
Fragonara e con note sulle principali tecniche utilizzate a cura di Vladimiro Elvieri il
quale ci fa anche conoscere gli obiettivi dell’iniziativa, "un tentativo di far
conoscere ed apprezzare al pubblico, cremonese e non, opere ….che rappresentano un
ampio panorama delle diverse tendenze nell’ambito della ricerca incisoria
contemporanea internazionale. Si tratta di lavori eseguiti con metodologie in cui la
componente manuale ed artigianale svolge un ruolo preminente e che utilizzano, per la resa
finale dell’immagine (come indica il titolo della mostra), il torchio calcografico o
la pressa xilografica. Lo stesso torchio (a parte qualche piccola modifica) che per 4
secoli ha stampato le immagini che hanno costituito, sino all’avvento della
fotografia, la più importante fonte di divulgazione e di scambio culturale nella storia
dell’uomo. Non solo come riproduzione di monumenti e sculture o pitture, ma
grafica Marco
Fragonara e con note sulle principali tecniche utilizzate a cura di Vladimiro Elvieri il
quale ci fa anche conoscere gli obiettivi dell’iniziativa, "un tentativo di far
conoscere ed apprezzare al pubblico, cremonese e non, opere ….che rappresentano un
ampio panorama delle diverse tendenze nell’ambito della ricerca incisoria
contemporanea internazionale. Si tratta di lavori eseguiti con metodologie in cui la
componente manuale ed artigianale svolge un ruolo preminente e che utilizzano, per la resa
finale dell’immagine (come indica il titolo della mostra), il torchio calcografico o
la pressa xilografica. Lo stesso torchio (a parte qualche piccola modifica) che per 4
secoli ha stampato le immagini che hanno costituito, sino all’avvento della
fotografia, la più importante fonte di divulgazione e di scambio culturale nella storia
dell’uomo. Non solo come riproduzione di monumenti e sculture o pitture, ma  anche come tecnica
autonoma d’invenzione, capace di esprimere e comunicare le emozioni più profonde
dell’animo
anche come tecnica
autonoma d’invenzione, capace di esprimere e comunicare le emozioni più profonde
dell’animo  umano."
umano."
La rassegna cremonese si ispira anche ad un altro e non secondario fine, quello
di contribuire a chiarire alcuni dei termini di un’annosa, e mai risolta, diatriba
relativa ai metodi della stampa d’arte e che vanno a confluire nella generica
definizione di "grafica".
La scelta del torchio come protagonista di questa antologica, infatti, è- prosegue
Elvieri- una scelta che non va considerata come discriminante verso altri metodi di
riproduzione seriale, quali la litografia o la serigrafia e persino la stampa al computer
o alla fotografia, ma una necessaria puntualizzazione per poter far meglio comprendere non
solo al vasto pubblico, ma persino a molti operatori del settore, il variegato mondo
dell’incisione.
MANTOVA – "Raffaello e la sua scuola" a Palazzo
Te, capolavoro di Giulio Romano, l’allievo prediletto
Mantova, nella splendida dimora dei Gonzaga a Palazzo Te, propone un nuovo
incontro con il Rinascimento attraverso le opere di Raffaello, dopo quelle di Giulio
Romano e Leon Battista Alberti.
 "Roma e lo
stile classico di Raffaello 1515-1527" è promosso dal Centro Internazionale
d’Arte e Cultura di Palazzo Te, la Città di Mantova, la Graphische Sammlung
Albertina di Vienna e la Regione Lombardia e ha come obiettivo quello di dispiegare ad un
pubblico particolarmente attento una specifica fase artistica raffaellesca, in cui il
Maestro si avvicina sempre più all’arte classica e, nel contempo, si avvale in modo
sistematico dell’aiuto di allievi. L’opera di Raffaello e quella dei suoi
giovani scolari diviene, a partire proprio dal 1515, così strettamente connessa che
l’attribuzione di alcuni dei disegni ritenuti di Giulio Romano e di Giovanni
Francesco Penni è stata rimessa in discussione, con il risultato che, alla fine
dell’analisi, essi sono stati restituiti al Caposcuola.
"Roma e lo
stile classico di Raffaello 1515-1527" è promosso dal Centro Internazionale
d’Arte e Cultura di Palazzo Te, la Città di Mantova, la Graphische Sammlung
Albertina di Vienna e la Regione Lombardia e ha come obiettivo quello di dispiegare ad un
pubblico particolarmente attento una specifica fase artistica raffaellesca, in cui il
Maestro si avvicina sempre più all’arte classica e, nel contempo, si avvale in modo
sistematico dell’aiuto di allievi. L’opera di Raffaello e quella dei suoi
giovani scolari diviene, a partire proprio dal 1515, così strettamente connessa che
l’attribuzione di alcuni dei disegni ritenuti di Giulio Romano e di Giovanni
Francesco Penni è stata rimessa in discussione, con il risultato che, alla fine
dell’analisi, essi sono stati restituiti al Caposcuola.
Motivo centrale della mostra è, inoltre, la rappresentazione degli sviluppi
dell’arte a Roma dalla morte di Raffaello, nel 1520, fino al Sacco  di Roma, nel 1527; a
partire da tale data, infatti, la diaspora degli artisti dalla Capitale favorì a
diffondere gli stilemi raffaelleschi non solo in Italia ma anche presso le più
prestigiose corti europee.
di Roma, nel 1527; a
partire da tale data, infatti, la diaspora degli artisti dalla Capitale favorì a
diffondere gli stilemi raffaelleschi non solo in Italia ma anche presso le più
prestigiose corti europee.
Le quasi 300 opere in esposizione nella rassegna mantovana, provenienti dalle
più importanti Collezioni d’Europa e degli Stati Uniti, forniranno esaurienti
motivazioni al percorso proposto, quello di un’analisi globale delle molteplici
relazioni ed interazioni di artisti quali Giovanni da Udine, Perin del Vaga, Polidoro da
Caravaggio, Marcantonio Raimondi ed altri, oltre, naturalmente, l’imprescindibile e
prediletto allievo di Raffaello, genius loci di Palazzo Te, Giulio Romano.
SIENA – Jacopo della Quercia e la Fonte Gaia
Un’interessante mostra–cantiere didattico apre dal 1 marzo fino al 30
ottobre, al "fienile" del complesso di Santa Maria della Scala, in Piazza Duomo,
a Siena.
Si tratta di una mostra in progress che documenta l’iter dei lavori
della famosa FONTE GAIA, opera straordinaria di Jacopo della Quercia. L’iniziativa è
stata promossa dall’Istituzione Santa Maria della Scala e dall’Opificio delle
Pietre Dure di Firenze che, dieci anni fa dette inizio al progetto di restauro. Il
progetto partiva da una prima fase diagnostica, e, via via, attuava il ripristino dei vari
pezzi della fontana di piazza del Campo senese. L’ipotesi ultima era quella di
rimontare il monumento restaurato all’interno di una adeguata struttura, identificata
nel complesso di Santa Maria del Fienile.
Alla metà del secolo scorso, infatti, le condizioni della fonte erano talmente
compromesse da far nascere l’idea di sostituire il monumento con una sua copia. Nel
1858 ne venne affidato l’incarico esecutivo a Tito  Sarrocchi così che, nel 1869, la "nuova" fontana poté
essere ricollocata in Piazza del Campo, in una posizione leggermente diversa da quella
originaria e priva delle due statue e dei pilastri terminali, e solennemente inaugurata.
Sarrocchi così che, nel 1869, la "nuova" fontana poté
essere ricollocata in Piazza del Campo, in una posizione leggermente diversa da quella
originaria e priva delle due statue e dei pilastri terminali, e solennemente inaugurata.
L’esposizione odierna, comprende i pezzi fin qui restaurati
dall’Opificio delle Pietre Dure, le copie esistenti (disegni e gessi), spesso assai
più completi degli originali, ed offre informazioni sul progetto finale di ricomposizione
della struttura, ove i singoli pezzi ritroveranno, ciascuno, una propria sistemazione. La
qualità artistica dell’opera appare a tutt’oggi in tutta la sua integrità,
nonostante il degrado del tempo, ed in modo particolare in una delle più affascinanti
figure del complesso, quella di Acca Larentia che è anche tra le sculture più
significative del primo Rinascimento italiano.
MILANO – L’anima e il volto. Ritratto e fisiognomica
da Leonardo a Bacon
 Chiuderà i
battenti il 14 marzo la ricchissima mostra di Palazzo Reale dedicato ad oltre duecento
capolavori di arte europea attraverso i quali si sviluppa il tema della rappresentazione
del volto umano quale portavoce di un'interiorità.
Chiuderà i
battenti il 14 marzo la ricchissima mostra di Palazzo Reale dedicato ad oltre duecento
capolavori di arte europea attraverso i quali si sviluppa il tema della rappresentazione
del volto umano quale portavoce di un'interiorità.
Cinque secoli di pittura che narrano il concetto che l’uomo occidentale ha
avuto del sé esteriore, del corpo e del volto, che  traduce iconograficamente l’evoluzione del pensiero
relativamente all’esistere su questa terra.
traduce iconograficamente l’evoluzione del pensiero
relativamente all’esistere su questa terra.
Riprendendo le parole di Leonardo, Flavio Caroli, curatore del consistente
catalogo che il Comune di Milano ha voluto dedicare alla memoria di Federico Zeri, cita:
"Farai le figure in tale atto il quale sia sufficiente a dimostrare quello che la
figura ha nell’animo; altrimenti la tua arte non sarà laudabile". Indizio
chiaro di come l’evoluzione dello studio della Psicologia – che affonda le sue
radici nella preistoria della Fisiognomica,- abbia un percorso parallelo a quello
dell’arte.
 Anzi, ed è la tesi che
apoditticamente si auto certifica nel percorso della mostra, il fondamento stesso
dell’arte occidentale si pone come individuazione personale dell’interiorità
dell’uomo. Ciò non avviene in altre culture figurative: non in quella cinese "lirica
e naturalistica. Non a quella bizantino-russa, trascendente e spiritualistica. Non a
quella islamica, iconoclasta. Non a quella indiana, plastica e decorativa. E nemmeno a
quella africana, sintetica e, a suo modo, formalistica"(F.Caroli).
Anzi, ed è la tesi che
apoditticamente si auto certifica nel percorso della mostra, il fondamento stesso
dell’arte occidentale si pone come individuazione personale dell’interiorità
dell’uomo. Ciò non avviene in altre culture figurative: non in quella cinese "lirica
e naturalistica. Non a quella bizantino-russa, trascendente e spiritualistica. Non a
quella islamica, iconoclasta. Non a quella indiana, plastica e decorativa. E nemmeno a
quella africana, sintetica e, a suo modo, formalistica"(F.Caroli).
L’itinerario della mostra, già di per sé straordinario per la
possibilità d’incontro che  offre con i capolavori di
artisti europei famosi nel mondo, trova un ulteriore gratificante sostegno nei saggi del
catalogo, edito da Electa. Oltre alla già menzionata introduzione di Flavio Caroli,
"Cinque secoli di pittura verso il Profondo", sono di Marcello Cesa-Bianchi e
Carlo Cristini "Fisiognomica, arte e psicologia". Ed inoltre, vi si trovano
analisi relative ai ritratti nell’arte di varie epoche e regioni ed altre che
indagano sullo stretto rapporto esistente tra fisiognomica e psicologia. Vi è inclusa
anche un’interessante ed aggiornata relazione sul restauro della "Testa di
Medusa" di Caravaggio, le cui precarie condizioni hanno impedito partecipasse alla
mostra milanese.
offre con i capolavori di
artisti europei famosi nel mondo, trova un ulteriore gratificante sostegno nei saggi del
catalogo, edito da Electa. Oltre alla già menzionata introduzione di Flavio Caroli,
"Cinque secoli di pittura verso il Profondo", sono di Marcello Cesa-Bianchi e
Carlo Cristini "Fisiognomica, arte e psicologia". Ed inoltre, vi si trovano
analisi relative ai ritratti nell’arte di varie epoche e regioni ed altre che
indagano sullo stretto rapporto esistente tra fisiognomica e psicologia. Vi è inclusa
anche un’interessante ed aggiornata relazione sul restauro della "Testa di
Medusa" di Caravaggio, le cui precarie condizioni hanno impedito partecipasse alla
mostra milanese.
PASIANO (Pordenone) – "Dalle radici il
volo" personale di Vittorio Buset a Villa Saccomani
 Non si tratta di astrattismo, sebbene alcune figure siano
talmente semplificate ed esemplari nelle loro geometrie pulite, da indurre a credere che
il naturalismo formale sia stato sostituito con la sola "forma" degli oggetti
che Buset usa utilizzare per le sue composizioni.
Non si tratta di astrattismo, sebbene alcune figure siano
talmente semplificate ed esemplari nelle loro geometrie pulite, da indurre a credere che
il naturalismo formale sia stato sostituito con la sola "forma" degli oggetti
che Buset usa utilizzare per le sue composizioni.
In esse, invece, è sempre presente la storia, anche se si tratta di una storia
personale e spirituale che si serve come veicolo espressivo di materiali, spesso poveri,
sabbie, legni, graniglie sassose, tritume di pietrisco che, stranamente, ben si prestano a
narrarla.
Difficile non vedere in opere quali, ad esempio "Radici del volo" un
pensiero, un’analisi o forse soltanto un’esplicitazione inconscia di un vissuto,
un’esplorazione dell’io interiore: La base della composizione è costituita da
un intenso elemento sotterraneo, una vita primigenia, una specie di mito della caverna,
dove la caverna rappresenta il ricettacolo di un’energia tellurica e ctonia e
raffigura contemporaneamente (e forse fin dall’epoca delle caverne paleolitiche) il
centro spirituale del macrocosmo, progressivamente oscurato, e quello del microcosmo del
mondo e dell’uomo. Un sottile filo bianco che promana dal mondo cresce sopra la
caverna, traccia un’asse che non si ferma ai confini fisici dell’universo, ma
continua nel suo viaggio e si incarica di unire il cielo e la terra, di pacificare il
presente e il passato.
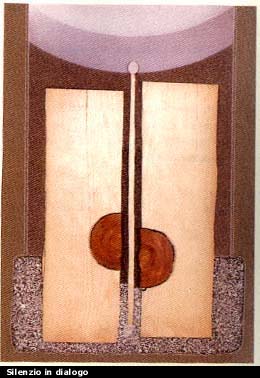 Verrebbe la tentazione di applicare ad opere come questa il termine di
neometafisica, se non fosse che qualsiasi etichetta rischia di divenire riduttiva e
limitante per uno che, come Vittorio Buset, non considera certamente chiusa la sua
ricerca. Assemblando sostanze materiche che raccoglie dalla quotidianità di un passato
trascorso tra le cose semplici di un mondo semplice ma ricco di stupore, di scoperte, di
affetti, egli cerca di ricostruire una storia spirituale presente, una storia che è pure
ugualmente legata al mondo ma che è anche in grado di percorrere una via di armoniosa
separazione da esso, di immersione in un silenzio che solo permette l’incontro con se
stessi.
Verrebbe la tentazione di applicare ad opere come questa il termine di
neometafisica, se non fosse che qualsiasi etichetta rischia di divenire riduttiva e
limitante per uno che, come Vittorio Buset, non considera certamente chiusa la sua
ricerca. Assemblando sostanze materiche che raccoglie dalla quotidianità di un passato
trascorso tra le cose semplici di un mondo semplice ma ricco di stupore, di scoperte, di
affetti, egli cerca di ricostruire una storia spirituale presente, una storia che è pure
ugualmente legata al mondo ma che è anche in grado di percorrere una via di armoniosa
separazione da esso, di immersione in un silenzio che solo permette l’incontro con se
stessi.
G.G.